Un palestinese con i capelli arancioni, e con una kefiah dello stesso colore quale accessorio distintivo, non se ne vedono di frequente ma sono i tratti che rendono speciale ed unico il protagonista di questo romanzo, in cui leggiamo una storia di amicizia che si staglia sullo sfondo della storia di un popolo di cui oggi, forse più che mai, sentiamo parlare e leggiamo quotidianamente.
IL RAGAZZO CON LA KEFIAH ARANCIONE
di Alae Al Said
 |
Ponte alle grazie
484 pp |
Quando, nel 1994, Loai Qasrawi, palestinese nato e cresciuto ad Al Khalil, in Cisgiordania, si ritrova davanti un giornalista americano venuto per ascoltare la storia della sua fabbrica di kefiah, comincia a parlare di sé, a raccontare la propria storia e quella di un amico carissimo il cui dolce, e insieme amaro, ricordo è strettamente legato a una kefiah arancione.
Negli anni Sessanta Loai è un ragazzino dai capelli rossi, dalla corporatura minuta e dal carattere timido; portato per lo studio, è uno di quegli studenti che a scuola si distinguono per essere brillanti, attenti, diligenti nei compiti ma non a tutti piace questa sua naturale inclinazione ad essere il primo della classe.
Ad esempio, non piace ad Amir, un compagno di classe che - chissà perché, poi!? - lo detesta con tutto sé stesso, non tanto perché Loai è bravo ma per via dei suoi capelli arancioni.
I suoi capelli fiammeggianti spiccano su quel corpo, agli occhi dei compagni prepotenti, insignificante, e costituiscono una sorta di richiamo perché il tranquillo Loai divenga un facile bersaglio per atti feroci di bullismo.
Non solo, ma ad essere motivo di dileggio sono anche le kefiah realizzate dall'azienda della famiglia di Loai, che produce tra l'altro bellissime e particolari kefiah di colore arancione.
Non passa giorno senza che Loai non venga preso di mira da Amir&co., i quali lo tormentano, lo umiliano e lo rendono oggetto di scherno con i loro comportamenti scorretti e perfidi, che vanno ben oltre i semplici dispetti tra compagni di classe.
E gli adulti attorno - tranne la giovanissima e bella insegnante di Matematica - sembrano non farci caso, declassando tutto a innocenti ragazzate; a casa, se la mamma e il fratello maggiore di Loai danno importanza alla sofferenza del ragazzo (il quale comincia addirittura a odiare la scuola, proprio lui che è sempre stato il tipico secchione), il padre è oltremodo irritato da questi piagnistei ed è convinto che questi episodi che fanno piangere il figlio, in realtà gli torneranno utili in quanto lo renderanno uomo e più pronto ad affrontare la vita, che è dura e aggressiva.
La consolazione che Loai non riesce a trovare in classe e neppure in casa, la trova casualmente per strada, una mattina in cui ha marinato la scuola, ed ha il nome e il volto di un ragazzino poco più grande di lui: Ahmad.
L’incontro con Ahmad, ragazzo povero ma forte e sicuro di sé, che soffre per una difficile situazione famigliare (che lo porta a stare il più possibile lontano da casa) gli offre una via di fuga e un modo per accettarsi: insieme condividono sogni di riscatto, si aprono, si raccontano, si sfogano e nasce un’amicizia speciale, di quelle che capitano poche volte nella vita e che sembrano davvero destinate a durare per sempre.
La loro amicizia si fa ogni giorno più stretta e vigorosa, è un punto di riferimento per entrambi, aiutandoli ad affrontare con più coraggio i piccoli, grandi problemi della vita, e anche se qualche screzio non mancherà e sembrerà allontanarli, il legame che li avvicina è troppo forte per essere spezzato.
" quell’amico gagliardo, fragile, orgoglioso e sognatore, ogni volta si scopriva emozionato al pensiero di rivederlo. Anche se si era trovato dei buoni compagni e la sua vita era cambiata, un’amicizia come quella non gli si ripropose mai più."
Negli anni dopo la scuola, i due si perdono di vista ma le loro strade tornano ad incrociarsi - sempre apparentemente per un puro caso - nel corso di un periodo storico tra i più dolorosi per i palestinesi.
Loai e Ahmad vivono, prima con speranza e poi con angoscia, gli eventi che conducono alla Guerra dei sei giorni, al termine della quale Israele avrà conquistato Cisgiordania, Striscia di Gaza, il Sinai e le Alture del Golan, assumendo il controllo di territori abitati per lo più da arabi palestinesi.
Si apre una nuova e ancor più drammatica fase dell'occupazione israeliana: la prepotenza e la violenza - proprio come, in piccolo, era successo al giovanissimo Loai negli anni della scuola - si abbattono spietate sui due smarriti amici e sull’intero loro popolo; Loai ha di nuovo Ahmad al suo fianco, ma la realtà in cui vivono è troppo dura e la tragedia è dietro l'angolo, non solo per loro due ma per tutte le famiglie palestinesi che si vedono piombare in casa militari israeliani, che si vedono cacciati dalle loro case, che si vedono puntare addosso fucili, arrestati, maltrattati nel corpo e nell'anima, uccisi.
"Cosa si prende da una casa poco prima di diventare profughi? Cosa si prende con sé poco prima di diventare esuli, di raggiungere una tenda in cui si passerà il resto della propria esistenza, lontano da tutto, anche da sé stessi?"
" Non sarebbero state le foto e neanche tutte quelle cose ammassate dentro le lenzuola a ricondurla alla casa. Sarebbero state le chiavi. Giacché le chiavi riassumono l’essenza di un’abitazione: chiudono e riaprono eternamente la culla della memoria. Sarebbero tornati, presto sarebbero tornati, si disse. E anche se gli invasori avessero cambiato la serratura, non importava, quelle chiavi avrebbero custodito i ricordi impressi tra quelle mura."
I dolorosi giorni della Nakba (catastrofe) di diciannove anni prima, ancora impressa nella memoria dei palestinesi, sembrano non dover finire mai e tra queste pagine avvertiamo con forza tutta la sofferenza di un popolo costretto a vivere sotto occupazione in casa propria.
Il bullismo subito dal protagonista quando era solo un ragazzino si riflette, in scala maggiore, nella violazione dei diritti del popolo palestinese da parte della potenza occupante, Israele.
Il ragazzo con la kefiah arancione è un romanzo che commuove, emoziona, fa riflettere grazie ai temi presenti e alla genuina intensità con cui vengono trattati: l'amicizia, il bullismo, i legami famigliari, le tradizioni e l'attaccamento alle proprie radici, le ingiustizie, la sumud (perseverare nella resistenza; cosa che ai palestinesi riesce parecchio bene), la resistenza (che inevitabilmente implica la lotta), il perdono, e tutto sullo sfondo di una terra martoriata e di un popolo che nella capacità di resistere ha mostrato la propria forza, rivendicando tenacemente il diritto alla propria terra.
L'autrice è stata molto brava e convincente nella costruzione dei personaggi (principali e secondari), dei quali comprendiamo i caratteri, le aspirazioni, le fragilità, del contesto storico e del periodo di riferimento (dal 1961 al 1994) e dà modo al lettore di ripercorrere alcuni tratti salienti del cosiddetto "conflitto arabo-israeliano".
Toccanti le parole usate da un giovane Ahmad nel riflettere sul significato che cela la trama della kefiah palestinese:
«Guardatela, non vi sembra una recinzione? Il loro progetto (degli israeliani) è rinchiuderci dentro una grande prigione. È già successo con i profughi del Quarantotto, sono isolati e dimenticati. Quindi, la recinzione sulla kefiah potrebbe essere la metafora del dramma palestinese»."
La kefiah racconta l’aspirazione alla libertà; indossandola, i palestinesi sentono di appartenere a qualcosa di più grande, affermano semplicemente di esserci, di esistere."Ed essere, avere dei diritti, uno stato in cui possano riconoscersi, è l’unica cosa che vuole questo popolo".
Lo consiglio, è un libro che non lascia indifferenti, tanto più che sotto i nostri occhi si sta consumando un genocidio a danno dei palestinesi.
Citazioni
"la rida, una richiesta di benedizione che i figli fanno ai propri genitori: è un promemoria del desiderio di essere accettati. Erda alay significa ‘accettami per ciò che sono, con i miei errori e le mie debolezze
di figlio’, significa ‘sii grato per ciò che sono, nonostante tutto. Anche se a volte posso sembrare ingrato, distante o assente’. Erda alay è una supplica per l’accettazione e la gratitudine, un invito a trovare pace in un dono divino. È il desiderio umile di un figlio di sentirsi accolto e amato tra le braccia dei propri genitori. Significa ‘perdonami, accettami, concedimi la tua benedizione e chiedi a Dio di benedirmi’.
A questa richiesta, il genitore risponde Allah yerda alek, che significa ‘che Dio ti conceda il perdono e la benedizione, perché io lo farò’. È un momento meraviglioso, perché la preghiera di un genitore a Dio è inappellabile. Erda alay significa anche ‘non andare contro di me, non lamentarti di me davanti a Dio’. Annulla ogni rancore, ogni risentimento."
" a volte i sogni più belli li conserviamo nei luoghi più lugubri, inaspettati. Perché non ci crediamo abbastanza, perché ci sembrano impossibili."
" Ché non si muore mica quando si smette di respirare, si muore quando qualcuno ti strappa di dosso la dignità."
"se non si è liberi, non si può vagheggiare. Che la libertà è la chiave dei sogni, che solo una volta raggiunta si può pensare a sé stessi."
"Come era possibile che tutto stesse accadendo come diciannove anni prima? Non aveva vissuto la Nakba, eppure la Catastrofe era così nitidamente impressa nella sua memoria. Non quella personale, ma quella collettiva arrivata fino a lui. Alcune esperienze, alcuni momenti storici restano indelebili, sono così traumatizzanti che inglobano, si mangiano, tutti gli altri ricordi. Divengono il pilastro, la rappresentazione che abbiamo di noi stessi, le nostre radici, l’essenza di cui ci nutriamo e di cui si nutre la comunità. L’esilio forzato, il racconto della Nakba, tramandato da nonno a nipote, e di casa in casa, era divenuto l’elemento caratterizzante dell’identità di ogni palestinese. Anche chi non l’aveva vissuta poteva rammentarla, sentire quella ferita. Si dice che il vagito di un neonato palestinese sia più forte di quello degli altri bambini della terra; forse perché lo strappo dall’utero materno gli ricorda lo strappo dei suoi avi dalla terra natia.
Assorbiamo la storia del nostro popolo dal cordone ombelicale, mentre ci nutriamo della sostanza di nostra madre. Quella sostanza impregna in noi pezzetti di memoria collettiva, e non appena nasciamo, li ricongiungiamo alla realtà divenendo testimoni di un’ingiustizia epocale. Un bambino palestinese è un racconto che grida, che vuole essere narrato."


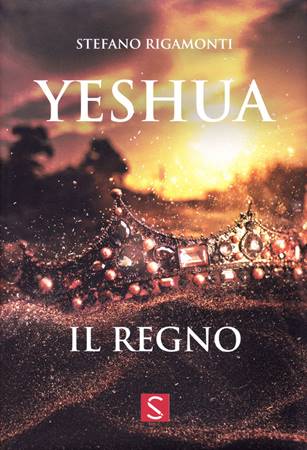


Ciao Angela, anche questa volta ci proponi un libro dal forte impatto emotivo, una storia che tratta temi attuali come il bullismo e le ingiustizie sociali.
RispondiEliminaCome sempre, bella recensione. Un abbraccio 😘
una lettura coinvolgente, sì, per le tematiche tristemente sempre presenti nella storia dell'umanità...
Eliminagrazie <3
Ciao Angela, non conosco il romanzo ma immagino la sua carica emotiva, soprattutto letto in questo periodo... Un abbraccio :-)
RispondiEliminaesattamente, in questo periodo non può che far riflettere ancora di più..
Eliminaun abbraccio <3
Ciao Angela, è sempre interessante quando la realtà e la Storia si fondono in un romanzo che mette in primo piano le tematiche identitarie e culturali. Prendo nota. Un abbraccio :)
RispondiEliminasì, esatto, aquila, in questo libro la storia del protagonista (con le sue personali ingiustizie subite) si intreccia con quella di un intero popolo.
Eliminaun abbraccio <3