Come e quanto ci cambia la malattia? In che modo cambia la percezione che abbiamo di noi stessi e quali nuovi termini utilizzeremo per poter descrivere questa "nuova versione" di noi?
E gli altri..., come ci vedono, con quali occhi? Quali nuove parole impareranno ad usare per parlare di
noi, del nostro corpo ormai irrimediabilmente malato, "guasto"?
L'Autrice, con onestà e lucidità, si guarda, si analizza, vede in questo corpo che, a un certo punto, ha cominciato a tradirla, tutta l'incertezza futura che l'aspetta e che dipenderà dal progresso della malattia - sclerosi multipla -, e in questo corpo danneggiato si specchia, riconoscendo tutta la propria fragilità umana, di donna, mamma, figlia.
BIANCO È IL COLORE DEL DANNO di Francesca Mannocchi
 |
| Einaudi Ed. 216 pp |
"ora so che ho un danno, che il mio danno è di colore bianco e che il condizionale è un modo miserabile.".
Ha trentanove anni Francesca quando la malattia fa il proprio improvviso ingresso nella sua esistenza.
Com'è svegliarsi in una camera d'albergo, da sola, e non sentire più alcune parti del proprio corpo?
(Solo a dirlo, più di un brivido di paura attraversa la mia schiena.)
Tornata a casa, la giornalista si affretta a sottoporsi a tutti gli esami necessari e scopre di avere una patologia cronica per la quale non esiste cura: sclerosi multipla, "una malattia autoimmune cronico-degenerativa che può essere ingravescente e colpisce il sistema nervoso centrale. Qui la parola chiave è ingravescente: «di situazione patologica che si aggrava progressivamente».
Si può aggravare. E progressivamente."
Si può aggravare. E progressivamente."
E ora?
Anzi, e da ora, che si fa? Come si gestiscono casa, famiglia, lavoro... con una spada di Damocle di questo genere sulla propria testa?
Francesca è una giornalista e il suo lavoro spesso la porta in zone di guerra, là dove la morte e le sofferenze sono all’ordine del giorno, ma questa nuova, personale presenza e forzata convivenza con un ospite decisamente indesiderato cambia il suo modo di essere madre, figlia, compagna, cittadina.
La malattia la mette davanti a sè stessa e la induce ad indagare nel profondo del proprio animo, ma anche nella propria famiglia, scavando nelle pieghe delle relazioni più intime, dove si sedimentano le parole non dette, i borbottii poco chiari che confondono e dividono, gli sguardi che dicono tutto nonostante ci si barrichi dietro muri di incomunicabilità e di frasi date per scontato.
E così il lettore si ritrova (autorizzato) a spulciare pagine di diario, a leggere di nonna Rita, diventata vedova piuttosto presto, e dell'attaccamento di Francesca a questa donna zoppa che andava a lavorare nella famiglia di uno stimato dottore; nonna Rita, la cui morte è stata difficile accettare ed elaborare, e che "è stata, inconsapevolmente, la mia educazione politica."
Leggiamo del rapporto con i genitori, in particolare con il padre, rinchiuso nella gabbia di un lavoro che non si è scelto spontaneamente, un uomo di poche parole e che non riesce ad esprimere alla figlia i propri sentimenti.
E poi c'è il compagno Alessio e il loro figlioletto Pietro; è il pensiero di lui, di questa creaturina che le appartiene e della quale è chiamata a prendersi cura in quanto madre, che la fa sentire smarrita, inadatta: non può, infatti, non domandarsi se sarà in grado di crescere suo figlio sapendo che la malattia potrebbe aggravarsi e renderla una mamma disabile.
"Che madre è una madre che ti promette l’altra sponda senza essere certa di potertici accompagnare? Che madre è una madre che raggiunta l’altra sponda può non saperti riportare a riva?"
La malattia non cambia solo il malato, ma anche i suoi famigliari e chi gli è attorno.
"La malattia di uno diventerebbe la malattia di tutti. La disabilità di uno, la disabilità della famiglia."
Come ti guarda e che pensieri formula chi sa che vivi portando su di te una malattia da cui non guarirai mai e che non tornerai più ad uno stato "pre-morbo"?
"Penso: è sempre lo sguardo degli altri che ci forma e ci deforma."
"Lo sguardo degli altri quando siamo malati ci tiene in ostaggio. Siamo prigionieri della pietà, della commiserazione, del difetto che può diventare principio e fine della nostra biografia."
Francesca è cosciente che lei non è la sua malattia; non è i "suoi sintomi", bensì è una donna con dei sintomi.
E dall'esterno, in fondo, neppure si direbbe che sta male, perchè finché sei inferma ma il "guasto" non si vede, puoi ancora cavartela e sfuggire agli sguardi curiosi e compassionevoli degli altri; ma quando il danno è evidente, non sei più solo un malato: sei vittima.
E la vittima si riconosce; di lei i sani hanno pietà, commiserazione, tolleranza.
"Essendo commiserato puoi commiserarti a tua volta e su questo costruire un pezzo di identità. Cosí il danno finisce per coincidere con quello che sei."
Essere malata ha costretto Francesca a riconsiderarsi sotto più aspetti, ad esempio come una cittadina che usufruisce di visite e cure che - se dovesse pagare - costerebbero un occhio della fronte; il dover andare di frequente in ospedale inevitabilmente la porta a conoscere il Paese attraverso le maglie della sanità pubblica, la mette a confronto con altri malati come lei ma anche con infermieri e medici che si occupano del suo corpo malato.
La malattia l'ha costretta a fare i conti con un modo di percepire lo scorrere del tempo differente da prima: ha imparato, ad esempio, in quanto paziente, che il mondo ospedaliero non è solo lo spazio della cura, perché dopotutto non è detto che la medicina abbia sempre tutte le risposte e tutte le cure, o che, dopo le cure, ci sia una guarigione, o che ancora, essa sia completa.
Francesca accetta che l'imponderabile che ha attaccato il suo cervello, il midollo spinale..., non è un problema risolvibile in senso definitivo e, anzi, davanti a patologie come la sua, la scienza medica si configura come lo "spazio dell’incertezza".
Neanche la terminologia viene in aiuto, in questi casi: già, perché la lingua della medicina non ha lo stesso vocabolario della gente comune e non coincide quasi mai col male che prova a descrivere, anzi lo imbriglia in gabbie rigide e sterili.
Scrivere, raccontare e raccontarsi diventa allora uno strumento per permettere alla Francesca di prima e a quella di oggi di incontrarsi e inventare una lingua nuova per mettere insieme i pezzi, per reinventarsi e riconoscersi attraverso l’esperienza della malattia, affrontando la paura di dover lasciare andare "il peso di una Francesca che non c’è più".
Ci narra, dunque, di malattia (e di percezione di sé, di come pensiamo che gli altri guardino il disabile), dell'approccio con gli aspetti medico-sanitari della propria nuova condizione di salute, ma anche dell'esperienza della gravidanza e della maternità, dei legami con i propri famigliari, della forza della memoria e dei ricordi, delle mille paure in quanto mamma che vorrebbe poter giurare al proprio bambino "Tranquillo, ci sarò sempre per te".
Per quanto mi riguarda, ogni scritto in cui l'autore trova il coraggio di parlare di sé, affrontando anche tematiche molto personali e facendolo con tanta onestà, merita di essere letto, quindi ve lo consiglio perché nelle parole di Francesca, nelle sue considerazioni, nell'esternazione di ogni paura, perplessità, incertezza, speranza..., il lettore può ritrovarsi.
Citazioni.
"È per gli altri che vogliamo essere perfetti, bellissimi, desiderabili.
È dagli altri che cerchiamo approvazione.
È l’altro che ci vede e vedendoci ci racconta, è l’altro a suggerirci chi siamo.
È lo sguardo, dunque, la gabbia?"
È dagli altri che cerchiamo approvazione.
È l’altro che ci vede e vedendoci ci racconta, è l’altro a suggerirci chi siamo.
È lo sguardo, dunque, la gabbia?"
"Custodiamo i ricordi con una cura eccezionale. Li trasformiamo in parole, immagini, fotografie, filmini, superotto, oscillando di continuo tra l’essere protagonisti della nostra vita e diventarne testimoni. Vogliamo che niente ci sfugga, che ogni evento possa diventare cimelio. I ricordi sono le narrazioni che ne facciamo, e noi, tutti, vogliamo raccontarli. Vogliamo raccontarci."
"...ho avuto un’idea precisa di cosa sia il ricordo quando il muscolo della memoria non viene allenato. Diventa proiezione dei dolori di altri, delle loro rimozioni, del modo di sopravvivere al presente, alterando il passato, se serve, oppure congelando i fatti che resistono a diventare ricordi."

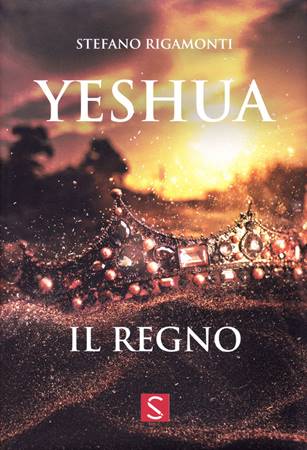


Nessun commento:
Posta un commento
Un buon libro lascia al lettore l'impressione di leggere qualcosa della propria esperienza personale. O. Lagercrantz